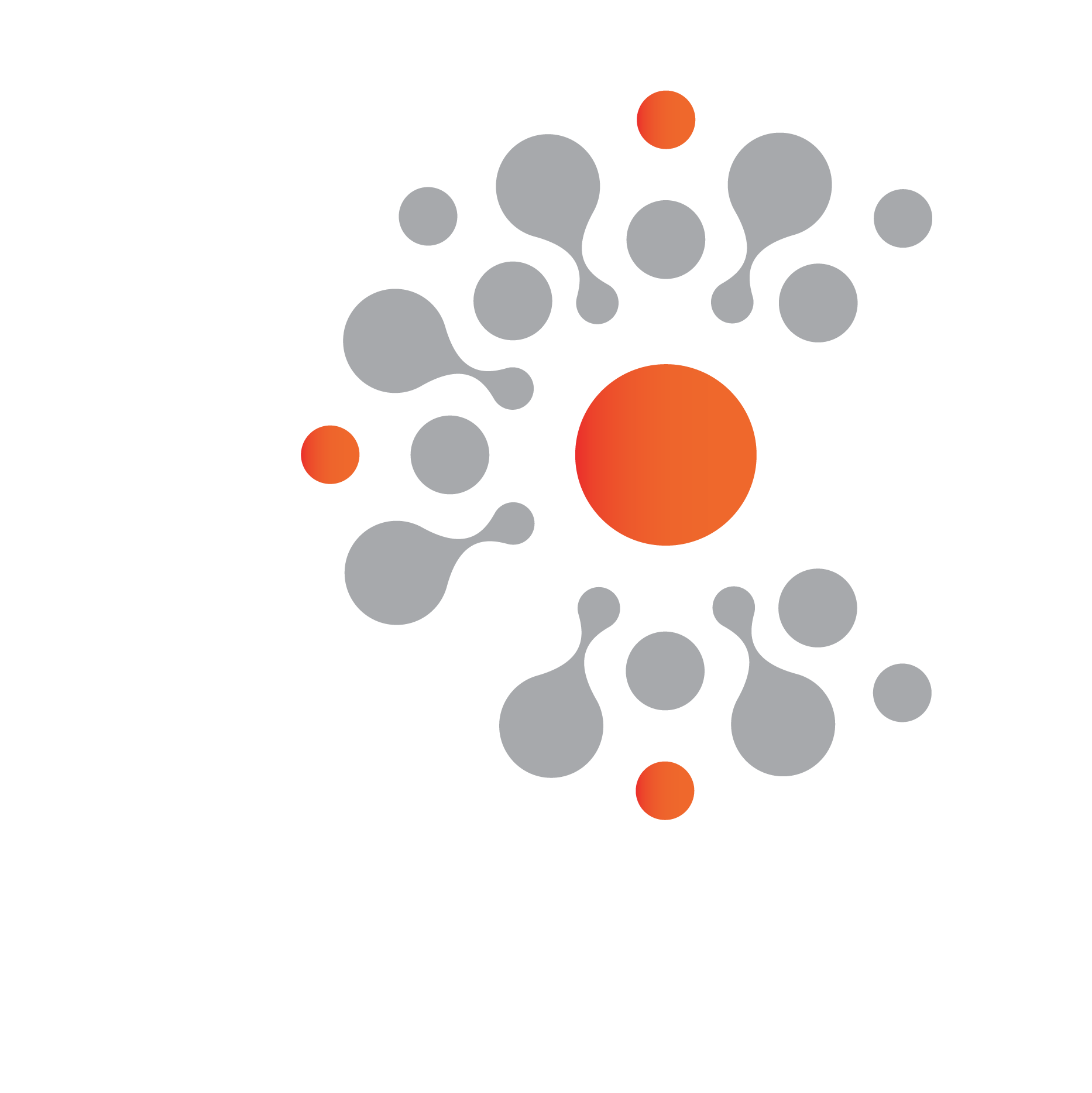7-11-2025 Sessione mattutina 9.00-13.00
Le guerre contemporanee: storia, geopolitica e potere globale
Francesco Strazzari politologo – Il disordine internazionale fra disumanizzazione bellica e pace imperiale
Abstract
L’acuirsi di rivalità e tensioni geopolitiche, la fine della deterrenza intesa sui binari lungo i quali si sono mossi fino ad anni recenti i rapporti fra stati, e il ritorno della guerra nella sua dimensione di massa sembrano segnare una fase di incerta transizione dell’ordine internazionale verso una configurazione multipolare, nella quale l’impianto normativo che ha orientato le relazioni internazionali negli ultimi trent’anni va dissolvendosi, con pesanti implicazioni per i diritti fondamentali. Quali sono le principali dinamiche che segnano questo passaggio? Come sta cambiando la guerra, quali scenari propongono le trasformazioni in corso e quali sfide per pensare la pace nell’ordine internazionale a venire?
Orietta Moscatelli giornalista – Guerra, da dove è venuta e dove va. Russia sempre più verso est e anche dentro
Abstract
Guerra “che non doveva esserci” e allo stesso tempo scontro annunciato, il conflitto in Ucraina è diventato il motore di inarrestabili cambiamenti e stravolgimenti degli assetti globali. Vladimir Putin, convinto che sarebbe bastata una dimostrazione di forza per indurre un cambio di regime in Ucraina, si ritrova a un teorico punto di partenza – rivendicando le stesse condizioni presentate a fine 2021 per evitare lo scontro – e di non ritorno: la traiettoria della Federazione Russa è segnata. Sull’orizzonte di un futuro comunque poco prevedibile si staglia una sempre più profonda cesura con l’Europa e con un Occidente che a Mosca faticano a definire, incerti se considerare l’America nel campo ostile o tra i possibili e necessari interlocutori. L’Europa, intesa come Unione Europea e Nato, sintetizza oggi nel discorso ufficiale russo la fonte di ogni male e l’immagine del declino a cui sottrarsi. E’ il nemico perfetto, come la Russia lo è per un’Unione Europea che di fronte all’annunciato disimpegno americano promuove il riarmo del continente. Da quasi quattro anni in guerra sul suo fianco occidentale, Mosca approfondisce la ‘svolta verso Est’, tra timori, speranze e in fin dei conti mancanza di alternative rispetto al consolidamento dell’asse con Pechino. Ai rispettivi vertici non c’è fiducia strategica, ma c’è la convinzione di dovere e potere percorrere assieme un cruciale pezzo di strada verso un invocato ordine “multipolare”, frutto ancora acerbo della crisi americana. Intanto il vettore orientale prende piede in Russia, dove la Cina diventa presenza anche nella sfera culturale e nel quotidiano. E dove le nuove generazioni crescono senza il mito dell’Occidente, mentre il sistema di potere attraversa una fase di transizione silenziosa ma profonda, proiettata verso il dopo-Putin.
Lorenzo Trombetta giornalista – Il Medio Oriente oggi, risultato di due secoli di frammentazione comunitaria
Abstract
Israele ha vinto militarmente sul terreno, ma politicamente contribuisce ad alimentare la violenza politica generata da sistemi di governo esclusivi, autoritari e clientelari. Dalla Siria all’Iraq passando per il Libano, il Mediterraneo orientale rimane imprigionato nella cultura della lottizzazione clientelare lungo linee di appartenenze comunitarie. Questa frammentazione fa il gioco delle potenze esterne che a occidente e a oriente riproducono una visione e una pratica neocoloniale.
Alessandra Russo politologa – Come definire rischio, minaccia, pericolo…paura: politiche europee di sicurezza e insicurezza
Abstract
La presentazione affronta il tema della sicurezza europea in considerazione delle crisi, dei conflitti e delle complesse manifestazioni di violenza politica nel vicinato – immediato ed allargato. In particolare, si rifletterà su come l’Unione Europea stia ridefinendo concetti tipici del pensiero strategico, con quali priorità, risorse e strumenti, ed affrontando quali tipi di tradeoff e dilemmi, sia politici, che normativi ed etici.
Geminello Preterossi filosofo – I pezzi si stanno saldando? Alle radici dell’ostilità globale
Abstract
L’inatteso sdoganamento della guerra totale, fino a ipotizzare la possibilità di vincerla, magari con l’uso di armi nucleari “tattiche” o altri mezzi analoghi di distruzione di massa, rappresenta un sintomo indicativo e inquietante di una crisi di civiltà. Di fronte alla deriva bellicista in atto e che ha contagiato potentemente l’UE, viene da chiedersi se non siamo ormai di fronte a un caso macroscopico di psicopatologia politica: sono in atto tutti i meccanismi difensivi descritti da Freud. Del resto, proprio Freud, in Il disagio della civiltà, ma anche nel suo epistolario-dialogo con Einstein, aveva tematizzato lo sfondo psicoanalitico della guerra. Indubbiamente contano i fattori geopolitici e geoeconomici (la trappola di Tucidide Cina-USA), pesa il cinismo degli interessi (anche inconfessabili), ma è in gioco anche una questione esistenziale, identitaria dalle implicazioni profonde, che toccano il lato oscuro dell’Occidente in crisi.
7-11-2025 Sessione pomeridiana 15.00-19.00
Guerra e potere economico: il motore finanziario del conflitto
Andrea Fumagalli economista – De-dollarizzazione dell’economia tra stabilità economica Usa e destabilizzazione monetaria dei paesi BRICS+
Abstract
L’intervento intende presentare le problematiche dell’economia degli Stati Uniti dopo l’introduzione della politica dei dazi e gli effetti sulla possibile tenuta del dollaro come moneta di riferimento internazionale in grado di finanziare il crescente indebitamento Usa, sia interno che estero, all’epoca del capitalismo delle piattaforme. È possibile che la politica corporativa di Trump riesca a rafforzare il potere finanziario del dollaro di fronte al crescente peso nell’economia e nel commercio mondiale dei paesi del Sud Globale? O invece, stiamo assistendo al declino dell’egemonia economica degli Stati Uniti con tutte le incognite che ciò comporta?
Maurizio Lazzarato sociologo e filosofo – L’accumulazione primitiva contemporanea
Abstract
Paradossalmente per parlare dell’economia di guerra, bisogna parlare di politica. Politica e economia sono indissociabili, ma si tratterà di vedere come cio’ che gioca un ruolo centrale in questa fase è la forza extra-economica, la volontà politica arbitraria e unilaterale di potere. La forza – extra economica è in funzione dell’economia, ma la riorganizzazione e ristrutturazione di quest’ultima passa per la guerra e la guerra civile.
Stefano Lucarelli economista – Il tempo di Ares. Politiche Internazionali, “leggi economiche” e guerre
Abstract
Quando una potenza egemone, debitrice verso l’estero, come gli Stati Uniti, dopo aver aperto i mercati, decide all’improvviso di cambiare l’ordine delle regole del gioco, svoltando dal liberoscambismo al protezionismo in modo unilaterale, a livello mondiale si apre una contesa. Sicché il grande debitore e i suoi alleati introducono dazi e sanzioni crescenti verso quei paesi che di fatto mettono in discussione gli assetti gerarchici che la globalizzazione immaginata all’inizio del millennio avrebbe dovuto invece consolidare. I paesi creditori, non solo la Cina, ma anche la Russia e altri Paesi riconducibili ai BRICS+, si rendono protagonisti di varie azioni di forza: si va dall’aggressione di tipo militare (è questo il caso dell’attacco russo in Ucraina), a un controllo territoriale al di fuori dei confini nazionali che sviluppa rapporti di forte dipendenza politica (si pensi alla presenza della Cina negli Stati africani in cui avviene l’estrazione delle terre rare).
I disordini del sistema internazionale che stiamo vivendo svelano la necessità di ridare un ordine alle relazioni fra grande debitore statunitense e grandi creditori orientali. Questi potranno difficilmente risolversi in modo durevole senza affrontare esplicitamente il ripensamento completo delle regole che reggono il sistema dei pagamenti internazionali. Avremmo bisogno di una nuova Bretton Woods, che regolamenti in modo coordinato i movimenti dei capitali internazionali, e che riponga in auge il grande tema di una valuta internazionale che non dipenda dalla potenza egemone.
Chiara Bonaiuti ricercatrice – L’Impatto occupazionale della spesa militare in europa, militarismo e tendenze insostenibili del capitalismo
Abstract
Il mio intervento verterà principalmente sulla presentazione di uno studio basato sulla metodologia input-output che confronta i moltiplicatori occupazionali degli investimenti pubblici in difesa, sanità, istruzione e ambiente nei paesi europei. I risultati della ricerca saranno poi contestualizzati, spiegando le peculiarità del mercato degli armamenti, l’evoluzione nel rapporto tra Stato e mercato dalla Guerra Fredda a oggi, con implicazioni per profitti, occupazione e rendite finanziarie. Al termine illustrerò brevemente in che misura il militarismo europeo si intreccia con alcune tendenze insostenibili del capitalismo occidentale attuale (finanziarizzazione, emergenza climatica, polarizzazione sociale), per condividere con i relatori e con il pubblico alcuni spunti di riflessione relativi alle traiettorie del capitalismo, al ruolo crescente del potere e dei rapporti di forza, sia in ambito economico che politico, e ai modi per sovvertirli.
Giorgio Beretta analista – Le esportazioni di armamenti dell’Italia e dei paesi UE: per quale sicurezza?
Abstract
L’intervento, illustrando i dati ufficiali delle Relazioni al parlamento europeo e italiano, metterà in evidenza le rilevanti quote di esportazioni di armamenti e sistemi militari da parte dell’Italia e dei paesi dell’Unione europea verso regimi autocratici e repressivi, a governi responsabili di gravi violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario tra cui la gran parte dei paesi arabi e Israele. Queste destinazioni rappresentano da anni una quota consistente dell’export di armamenti italiani ed europei ed è a queste esportazioni che è finalizzata un”ampia parte della produzione nazionale ed europea di sistemi militari.
8-11-2025 Sessione mattutina 9.00-13.00
Tecnologie belliche e impatti ambientali: nuove guerre, nuove ferite
Valentina Bazzarin ricercatrice – Il lato oscuro dei dati: etica e responsabilità nelle guerre ibride
Abstract
Viviamo in un tempo in cui le frontiere sono sempre più sfumate. Non solo quelle geografiche, continuamente ridefinite da conflitti che travalicano confini e norme, ma anche quelle giuridiche ed etiche: il diritto internazionale e umanitario viene spesso violato, le istituzioni vengono smantellate o svuotate della loro capacità esecutiva, mentre i riferimenti comuni della società europea e italiana appaiono fragili o assenti. In questo scenario di incertezza, anche l’etica pubblica si presenta come un oggetto sfocato, incapace di offrire coesione tra stati e cittadini.
All’interno di queste dinamiche, i dati diventano un terreno di conflitto ibrido. Strumenti essenziali per descrivere e prevedere scenari complessi, essi appaiono però “sporchi”: incompleti, distorti, manipolati. Nella maggior parte dei casi, vengono mobilitati da attori che mirano ad ampliare fratture sociali, economiche e politiche, alimentando disinformazione, polarizzazione e nuove forme di dominio. Troppo poco, invece, i dati vengono utilizzati per scopi di giustizia sociale: per rendere visibili le disuguaglianze, per misurare l’impatto delle politiche pubbliche, per guidare azioni collettive volte alla riduzione delle disparità e alla difesa dei beni comuni, inclusi l’ambiente e le risorse naturali.
Contrastare il “lato oscuro” dei dati significa innanzitutto riportare il discorso sull’etica pubblica e sui valori condivisi. Significa produrre dati di migliore qualità, trasparenti, accessibili e realmente utili per le comunità. Ma significa anche riappropriarsi della propria agency digitale, non delegando interamente le decisioni agli algoritmi, agli interessi e alle logiche opache di chi li disegna e li gestisce. Solo così è possibile recuperare responsabilità, rafforzare la fiducia e restituire ai dati un ruolo costruttivo, capace di sostenere processi democratici e inclusivi anziché diventare arma di nuove guerre ibride o territorio per l’occupazione.
Francesca Farruggia sociologa – Intelligenza artificiale e guerra: promesse, distopie e sfide globali
Abstract
L’evoluzione dell’intelligenza artificiale sta trasformando in profondità il modo di concepire e condurre la guerra. Ciò che un tempo apparteneva alla letteratura fantascientifica, dalle intuizioni di Alan Turing alle leggi della robotica di Isaac Asimov, è oggi al centro del dibattito internazionale su armi autonome letali (LAWS) e sistemi di decisione algoritmica. Le cosiddette “armi intelligenti” vengono presentate come strumenti capaci di garantire maggiore precisione, rapidità di intervento e riduzione delle perdite umane; al tempo stesso pongono questioni cruciali sul rispetto del Diritto Internazionale Umanitario, sul principio di responsabilità e sulla dignità umana.
Il ricorso a macchine capaci di selezionare e colpire obiettivi senza controllo umano significativo apre scenari distopici, in cui errori tecnici, attacchi avversari o bias algoritmici possono avere conseguenze irreversibili. La comunità scientifica, le organizzazioni umanitarie e la società civile internazionale hanno più volte richiamato l’urgenza di un bando preventivo o di una regolamentazione stringente, mentre l’opinione pubblica, in Italia come a livello globale, si è dimostrata in larga parte critica verso l’impiego delle armi autonome.
A partire da un’analisi critica dei rischi e delle opportunità dell’AI in ambito militare, affronteremo le sfide etiche, giuridiche e politiche poste dalle armi autonome, mettendo in luce la necessità di un dibattito pubblico informato e di un impegno multilaterale volto a garantire il controllo umano significativo sulle tecnologie belliche emergenti.
Paolo Cacciari giornalista e scrittore – Fare pace: disarmare
Abstract
La guerra è una forma di violenza estrema socialmente organizzata e pianificata che richiede una combinazione di fattori scatenanti: l’identificazione di un oggetto conteso (solitamente delle risorse territoriali); una giustificazione tale da ottenere l’”esaltazione dei popoli” (Bernard Russell, 1943) e relativo furore bellico; un apparato economico militare competitivo; ingenti risorse economiche da sottrarre ai bisogni sociali. La guerra non inizia con le armi. I generali vincono la loro guerra prima che si scateni, quando riescono ad ottenere il consenso. In conclusione la guerra va prevenuta con la smilitarizzazione, il disarmo, la cultura della nonviolenza. Cominciando con la riconversione degli apparati bellici: “Forgeremo le loro spade in vomeri, le loro lance in falci.” (Isaia 2,4). Elise Boulding ha scritto: “Le culture della pace prosperano dove le persone capiscono che la sicurezza non viene dalle armi, ma dalle relazioni.”
Francesco Vignarca analista di disarmo e spese militari – Costruire la Pace positiva attraverso il disarmo climatico
La pace non si limita all’assenza di conflitto, ma richiede un impegno attivo verso la giustizia nei rapporti tra Stati e comunità che ponga al centro non solo le persone ma anche l’ambiente. Un risultato che si può ottenere solo promuovendo sicurezza condivisa non protezione di privilegi o “territori”. Anzi l’ambito territoriale ed ambientale deve diventare alleati dei percorsi di pace: in tal senso il concetto di “disarmo climatico” ci invita a riconoscere le connessioni tra militarizzazione, crisi ambientale e conflitti. Ridurre il peso delle spese militari, disincentivare le guerre per l’energia e le risorse e orientare risorse verso la transizione ecologica diventano punti chiave (strategici) per un futuro sostenibile sia in termini di ecosistema che di cooperazione internazionale e ordine mondiale. Il focus di questa relazione saranno i percorsi di costruzione di una pace positiva in grado di superare la (falsa) logica bellicista della militarizzazione, ponendo al centro degli sforzi collettivi di società civile e (sperabilmente) politica la cura del pianeta e promuova modelli di sicurezza umana e climatica.
8-11-2025 Sessione pomeridiana 15.00-19.00
Odio, violenza, Male: il conflitto nella psiche e nella cultura
Alessandra Campo filosofa – Elogio di Thanatos, o dell’unica pace possibile
Abstract
Siamo tutti portati a pensare che la guerra sia un’espressione di ciò che Freud ha chiamato “pulsione di morte” e che “pulsione di morte” significhi volontà, desiderio, propensione al darsi, o a dare, la morte. In questo intervento, muovendo dall’interpretazione deleuziana di Thanatos, vorrei, al contrario, provare a sostenere che la guerra è conseguenza di un certo Eros, di un certo modo di legare la libido, di una certa ripetizione. Freud, infatti, ci ha insegnato che Thanatos, piuttosto, propizia il pensiero, e che la spinta che gli fornisce è alimentata dalla desessualizzazione, ossia dal movimento grazie a cui l’energia assoggettata da Eros al principio di piacere torna libera e può essere impiegata per nuovi fini. In altre parole: può essere sublimata. Deleuze invita a prenderlo alla lettera quando dice che l’istinto di morte è faccenda di speculazione: la speculazione è assicurata dalla desessualizzazione. Nel Fazer, Brecht la descrive come il “lavoro sotterraneo, capillare e instancabile, duro e incurante del risultato”, di riconoscimento dell’“ideologia senza parola” che insozza l’animo di ciascuno di noi senza che ce ne avvediamo. Spinoza come l’emendazione dell’intelletto che apre al terzo genere di conoscenza e allo specifico amore che lo sostiene: l’amor dei intellectualis. Ma non c’è differenza. L’unica forma di resistenza, l’unico antidoto all’aggressività e alla violenza, è la militanza, il servizio prestato nei confronti di ciò rispetto a cui ogni ente è strumento, medium, macchina: il pensiero. Dove c’è sesso, finché c’è sesso, ci sono solo morte, potere e distruzione.
Rocco Ronchi filosofo – Sumud: la guerra dei “non ancora eliminati”
Abstract
Quale forme può concretamente assumere la resistenza al genocidio? Coloro che non hanno più alcun potere materiale, quale potenza possono esercitare? Con l’espressione “non ancora eliminati”, Bertolt Brecht, nell’opera Ascesa e caduta della città di Mahagonny, indicava la condizione in cui si trova una umanità sulla quale pende la spada di Damocle della sparizione possibile. Alla filosofia spetta allora non solo denunciare l’orrore del genocidio, ma produrre concetti operativi che armino gli ultimi nella loro guerra per la sopravvivenza.
Ernesto C. Sferrazza Papa filosofo – La guerra tra natura e cultura
Abstract
L’intervento mira a inquadrare l’attuale dibattito filosofico sulla naturalità o meno della guerra, considerando le implicazioni politiche delle risposte che si possono fornire a questo problema. Negli ultimi tempi si è andata sempre più imponendo una interpretazione del fenomeno bellico come adattamento evolutivo dell’umano, utilizzando soprattutto acquisizioni recenti e ancora non pienamente stabilizzate di discipline quali la primatologia e l’etologia. L’intervento mostra i limiti e le contraddizioni di approcci di questo genere.
Andrea Panìco psicoanalista – Oltre la guerra
Abstract
I recenti conflitti che stanno coinvolgendo, direttamente o indirettamente, la società europea invitano a ripensare il tema della guerra. La relazione verterà sul contributo che la psicoanalisi può offrire in tal senso.
Alvise Marin direttore scientifico decentraMenti – Perché la guerra? Una riflessione psicoanalitica
Abstract
Questo intervento esplora le radici profonde della guerra, andando oltre le spiegazioni politiche o economiche. La psicoanalisi ci aiuta a comprendere come il conflitto nasca da dinamiche inconsce che riguardano ogni essere umano. Per Freud, la guerra affonda le sue origini nella colpa primordiale dell’uccisione del padre e nel conseguente senso di colpa che abita l’animo umano. L’uomo, attraversato da pulsioni di amore e di odio, tende a proiettare la propria aggressività all’esterno, trasformando l’altro in un nemico da distruggere. Franco Fornari interpreta la guerra come una difesa collettiva dal dolore e dal lutto: invece di accettare la perdita, proiettiamo fuori da noi le parti cattive e distruttive, costruendo un nemico simbolico. Allo stesso modo, Melanie Klein mostra come la mente umana, fin dall’infanzia, divida l’oggetto d’amore in buono e cattivo: una scissione che, a livello sociale, diventa la contrapposizione tra amico e nemico. Lacan infine collega la violenza al narcisismo e alla difficoltà di accettare la propria frammentazione interiore: l’altro rappresenta ciò che rifiutiamo di noi stessi. La guerra, quindi, è il riflesso esterno di un conflitto interno, il fallimento del lutto e del dialogo simbolico. Solo riconoscendo la nostra parte oscura e accettando la perdita possiamo spezzare la spirale della violenza. La pace non è solo un fatto politico: è prima di tutto un lavoro interiore, una riconciliazione con noi stessi e con l’altro.
9-11-2025 Sessione mattutina 9.00-13.00
Oltre la guerra
Cristina Morini giornalista e saggista – Nuovi processi di soggettivazione, femminismo e politica dell’impensato
Abstract
La guerra sembra presentarsi come forma della politica e dell’economia (ormai un binomio) prevalente nella contemporaneità. La normalizzazione della guerra entro gli orizzonti del pensiero collettivo ci costringe a riflettere sul potere e sul come riuscire a separarsi da esso. Ciò significa il ritorno in campo di processi di soggettivazione e cura di sé che non si sono realizzati positivamente nell’era della precarietà esistenziale. Inoltre, di fronte al rischio della morte e dell’annullamento, di fronte al possibile ricorso alle armi nucleari, al punto estremo della solitudine e della impotenza, possiamo riscoprire il ruolo e il valore, anche simbolico, dell’azione collettiva? Possiamo ritrovare forme di governo e cura di sé che favoriscano una liberazione dalle imposizioni del potere e dei suoi codici? La politica delle donne ha un tratto che scoperchia e vanifica le posizioni di potere, e potrebbe contrastare la riduzione della politica a guerra. Allo stesso modo, la politica dell’impensato (Foucault) può rappresentare una forma alternativa al crescere dei nazionalismi e all’imporsi della forza?
Paola Imperatore ricercatrice – Contro l’economia di guerra costruire economie sociali
Abstract
Se gli imperativi del profitto e l’accumulazione sfrenata hanno posto le basi per un’economia contro la società che oggi raggiunge il suo culmine attraverso il consolidamento dell’economia di guerra, ripensare le forme di produzione sociale è condizione necessaria per una fuoriuscita sistemica dalla violenza della guerra. Costruire un’economia per la società e non contro la società implica cogliere la sfida su più piani, e democratizzare la sfera della produzione affinchè sia la collettività a decidere “come, cosa e quanto produrre”. Non si tratta di un dibattito che coinvolge solo l’oggetto della produzione, ovvero il cosa produrre, ma piuttosto di una riflessione che chiama in causa anche il soggetto, ovvero il chi ha diritto di decidere cosa produrre.
Prendendo in considerazione modelli e pratiche di produzione situate in contesti diversi, questo contributo si propone di discutere la possibilità di costruire economie sociali, ecologiche, capaci di ricollocare il potere decisionale nella collettività e incentivare forme di cooperazione pacifica tra i popoli, messe sistematicamente a repentaglio dagli interessi di guerra delle élite politico-economiche.
Carlo Galli filosofo e politologo – Le forme della guerra, e la formula della pace
Abstract
Per cercare di delineare la configurazione di una pace possibile è ovviamente necessario comprendere le cause e le forme della guerra: di quella di oggi e di quelle del passato prossimo. La pace, infatti, nascerà (se mai ciò accadrà) non da esortazioni morali né da appelli astratti al diritto internazionale, ma dalla concreta soluzione delle questioni geopolitiche e geoeconomiche, e dal superamento delle interne contraddizioni delle potenze belligeranti, che hanno determinato l’attuale arco di crisi e l’attale ciclo di conflitti.
Raoul Kirchmayr filosofo – Autoimmunità, postdemocrazia, guerra
Abstract
Durante la globalizzazione economica degli anni Novanta e la conseguente instaurazione di un ordine politico unipolare le democrazie occidentali hanno subito un processo d’involuzione che si è dispiegato con la crisi del 2008 e che le ha condotte a mettere in discussione i loro stessi principi fondativi, al punto che ormai da tempo si parla di “postdemocrazia”. Cercheremo di comprendere quali sono le relazioni tra il mutamento in atto delle istituzioni democratiche e l’attuale fase di disordine mondiale che è a causa delle molteplici guerre in corso.
Pasquale Pugliese filosofo – Se vuoi la pace prepara la pace, con i saperi della nonviolenza
Abstract
La violenza della guerra non si esercita solo nella fase del suo pieno dispiegamento di distruzione e morte ma parte molto prima, attraverso i dispositivi strutturali e culturali che investono le dimensioni profonde della politica e della società per piegarle alle esigenze belliche. A cominciare dall’economia di guerra. Tuttavia, poiché le armi non sparano da sole, anche gli eserciti – con il progressivo ampliamento del numero dei soldati in tutta Europa – sono un elemento fondamentale della struttura che prepara le guerre. Ma la crescita delle spese militari – a svantaggio di welfare, scuola, sanità, ossia dei veri presidi di sicurezza – l’arruolamento dei giovani negli eserciti, la partecipazione dei Paesi (direttamente o indirettamente) alle guerre, affinché siano socialmente accettate hanno bisogno del supporto di un altro dispositivo più pervasivo: quello culturale, che si manifesta nelle dimensioni formative e informative che hanno lo scopo di legittimare e giustificare l’intera filiera.
Gli esempi recenti sono molteplici. Si va dal Segretario generale della Nato Rutte per il quale “è ora di passare ad una mentalità di guerra”, al Parlamento europeo che approva la relazione sulla “politica di sicurezza e di difesa comune”, nella quale impone ai paesi UE di “mettere a punto programmi educativi e di sensibilizzazione per i giovani volti a migliorare le conoscenze e a facilitare i dibattiti sulla sicurezza, la difesa e l’importanza delle forze armate”. Dal ministro della difesa Crosetto che ha costituito il “Comitato per lo sviluppo e la valorizzazione della cultura della Difesa” e moltiplica le incursioni dei militari nelle scuole, all’“isteria di guerra” (Edgar Morin) diffusa dalla maggior parte dei media, secondo i meccanismi consolidati della propaganda, fino al Censis che bacchetta il pacifismo degli italiani perché “indugia in un neutralismo autoreferenziale, inadatto a un’epoca segnata dal ritorno prepotente della politica di potenza come fattore essenziale dell’azione degli Stati a livello globale…”
Due sono i cardini del bellicismo che si perpetuano nel tempo, alimentando il pensiero magico della “deterrenza militare” e la costruzione del “Nemico”: il primo è l’irrazionale e obsoleto mantra secondo il quale per avere la pace bisogna preparare la guerra, smentito dall’aumento progressivo di conflitti armati, vittime civili e profughi corrispondente all’aumento delle spese militari globali per preparare le guerre. Il secondo è il doppio standard etico, secondo il quale un omicidio è un omicidio, ma moltiplicato per migliaia o milioni si chiama vittoria o, addirittura, pace. E’ il processo di “etificazione della violenza” (Judith Butler) ripudiato dagli obiettori di coscienza e dai disertori di ogni tempo ed esercito.
Si tratta dunque di ribaltare il paradigma bellicista nel suo opposto: per avere la pace – che non è solo fine della guerra – e mantenerla, bisogna preparare la pace. Costruendo e dispiegando i saperi della nonviolenza.