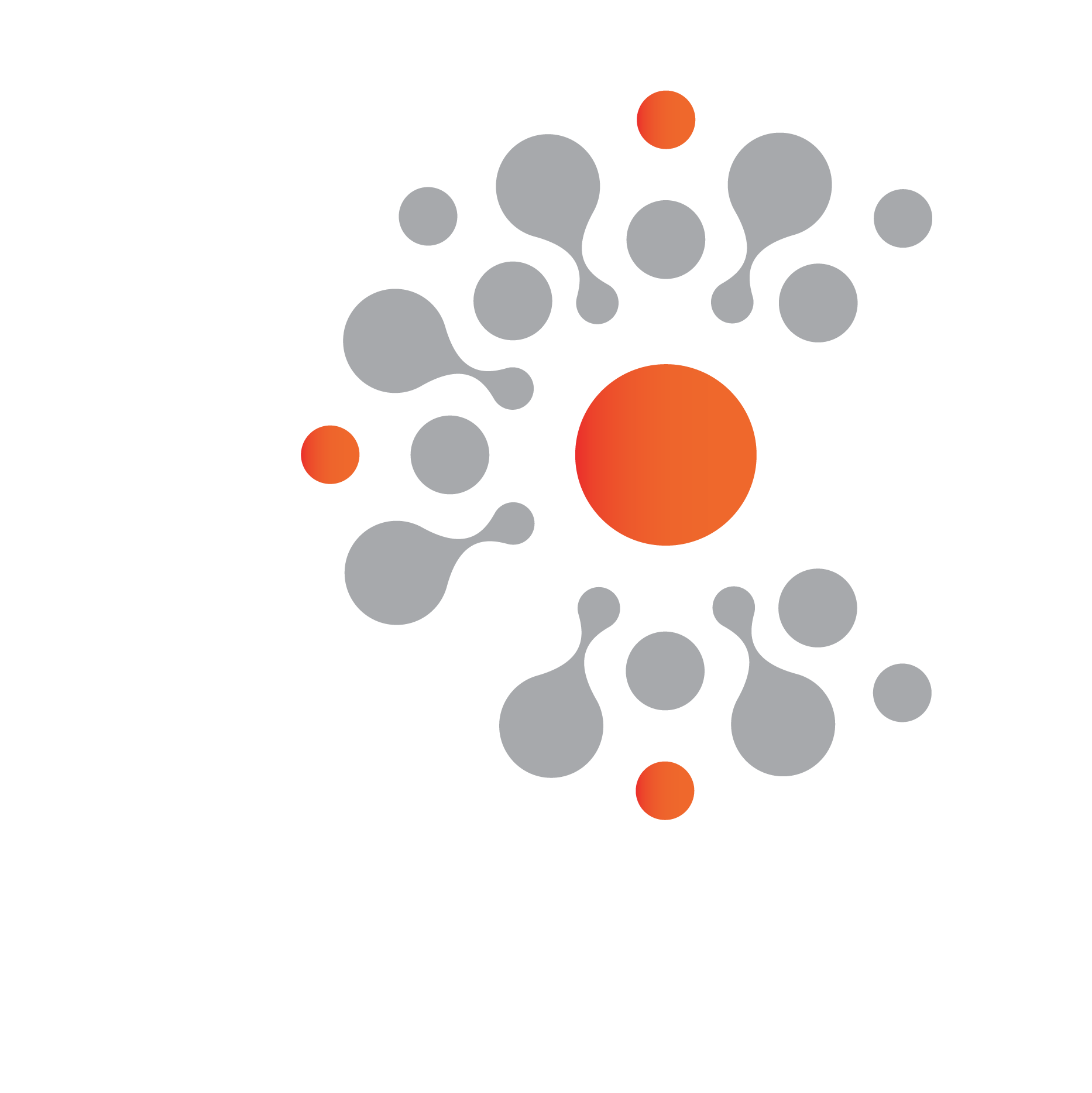Il seminario si propone di indagare alcune emergenze tematiche emerse dall’applicazione di algoritmi e intelligenza artificiale al mondo del lavoro.
Dalle mutazioni delle strutture organizzative a quelle dell’agency individuale e collettiva, dalla comparsa di nuove figure professionali all’impatto che le trasformazioni del lavoro hanno su corpi e affetti.
Con un’analisi del presente che vuole cogliere anche rischi e opportunità dei possibili sviluppi futuri.
L’evento è gratuito e si svolgerà il 28 Marzo 2025 alle ore 9:00 presso il Centro Culturale Candiani a Mestre (VE). E’ possibile partecipare anche da remoto via Zoom a questo link oppure componendo via telefono il +39 069 480 6488 (ID riunione 848 8159 4803; codice di accesso 718869)
Ore 9.00
Introduzione
Alvise Marin direttore scientifico di decentraMenti
Cinzia Maiolini segreteria nazionale Filctem CGIL
ore 9.30 – 13.00
Alessandro Simoncini, Lavoro digitale e data relations: estrazione/astrazione
Giorgio Pirina, Reincarnare il digitale: riflessioni sulla nocività socio-ecologica nel capitalismo
digitale
Andrea Fumagalli, Valorizzazione e ibridazione tra umano e macchinico nel capitalismo delle
piattaforme
Marco Marrone, Il potere infrastrutturale delle piattaforme (e come sfidarlo)
ore 15.00 – 19.00
Federico Chicchi, Governamentalità algoritmica e sintomatologia della società digitale
Sara Baranzoni, Homo Manutentor. Una lettura tecno-logica della proletarizzazione all’epoca
dell’Intelligenza Artificiale
Paolo Vignola, Noologia e tecnodiversità. Per una critica organologica dell’IA
Elia Zanin, Salute mentale tra algoritmi e trasformazioni del lavoro: a che punto siamo?

Biografie relatori.
Federico Chicchi è professore ordinario del Dipartimento di Sociologia e Diritto dell’Economia dell’Università di Bologna. Insegna inoltre presso l’Istituto di Ricerca di Psicoanalisi Applicata – IRPA (sede di Ancona). Svolge, attraverso un orientamento e una pratica transdisciplinare, attività di ricerca sulle trasformazioni del lavoro, dell’impresa e della soggettività nel capitalismo moderno e contemporaneo. È membro del comitato editoriale di numerose collane scientifiche e fa parte del comitato scientifico di numerose riviste. È autore di numerose pubblicazioni in italiano, francese, spagnolo e inglese. Ha scritto con Anna Simone il volume La società della prestazione (Ediesse/Roma, 2017) e la sua ultima monografia è dedicata al pensiero di Karl Marx , edita da Feltrinelli (2019).
Giorgio Pirina è laureato in Sociologia all’Università di Padova e ha conseguito il Dottorato in Sociologia e ricerca sociale all’Università di Bologna. I suoi interessi di ricerca concernono le conseguenze socio-ecologiche del capitalismo digitale, il lavoro di piattaforma e le disuguaglianze territoriali. Attualmente lavora come assegnista di ricerca all’Università Ca’ Foscari di Venezia, nell’ambito del progetto “Exit – Exploring sustainable strategies to counteract territorial inequalities from an intersectional approach” (Horizon Europe). È autore della monografia Connessioni Globali. Una ricerca sul lavoro nel capitalismo delle piattaforme (Franco Angeli Editore).
Elia Zanin, psicologo, neuropsicologo, psicoterapeuta, PhD in Neuroscienze cognitive e Filosofia della mente, è specialista in psicoterapia cognitivo-neuropsicologica. È autore di una decina di pubblicazioni su riviste scientifiche a carattere sia scientifico che filosofico, si occupa di psicoterapia negli adulti, valutazione e riabilitazione neuropsicologica.
Andrea Fumagalli, economista, è docente presso le Università di Pavia e di Varese. I suoi interessi di ricerca sono prevalentemente relativi alla teoria macroeconomica, alla teorie monetarie eterodosse, all’economia dell’innovazione, alla distribuzione del reddito e alle mutazioni del capitalismo contemporaneo. Tra i libri più recenti: Valore, Moneta, Tecnologia. Capitalismo e scienza economica, DeriveApprodi, Roma, 2021 ed Economia politica del comune, DeriveApprodi, Roma, 2017.
Sara Baranzoni, dottore di ricerca in Studi Teatrali e Cinematografici, ricercatrice in Filosofia presso “Pontificia Università Antonianum“. Collabora con l’IRI di Parigi, il network Digital Studies e l’Hemispheric Institute of Performance and Politics. Co-fondatrice della rivista La Deleuziana.
Paolo Vignola, assegnista di ricerca in filosofia morale presso l’Università degli Studi di Bergamo, è professore invitato e coordinatore scientifico del master in Etica e Intelligenza Artificiale presso la Pontificia Università Antonianum di Roma. È inoltre cofondatore della rivista La Deleuziana e condirettore della Scuola di filosofia “Prof. Challenger” di Lecco.
Marco Marrone ricercatore presso il dipartimento di scienze umane e sociali dell’Università del Salento. Autore di Rights Against the Machines! Mimesis edizioni.
Alessandro Simoncini insegna filosofia politica presso l’Università per Stranieri di Perugia. Tra le sue recenti pubblicazioni: Democrazia senza futuro? Scenari dall’interregno postdemocratico (2018); Populism and neoliberalism. Notes on the morphology of a “perverse alliance”, in “Interdisciplinary Political Studies” (nº 2, 2021); “Leer El capital: Foucault, Benjamin, Marx”, in “Areté. Revista de Filosofía” (nº 2, 2021) e Società della merce, spettacolo e biopolitica neoliberale. Studi per il pensiero critico (2022)
Tema.
Negli anni ’90 del secolo scorso, l’evoluzione delle tecnologie informatiche, aveva portato con sé una nuova narrazione, che annunciava un futuro ormai prossimo, in cui si sarebbe lavorato di meno, con meno fatica e più tempo libero, in un regime economico di crescita illimitata. Una narrazione che ripeteva pari pari un ritornello già ascoltato nelle promesse delle “rivoluzioni” tecnologiche precedenti. L’ideologia cool della New Economy, esplosa dopo la nascita di Internet, rendeva tutti tendenzialmente più felici e sfruttati1. Sappiamo tutti, per esperienza, com’è andata: «è da mezzo secolo che la qualità del lavoro sta peggiorando sempre più, sempre nella applicazione di quella razionalità strumentale/calcolante-industriale che cerca con ogni mezzo di accrescere la produttività e il pluslavoro per accrescere il profitto privato; e questo mediante flessibilizzazione e precarizzazione del lavoro, esternalizzazione e remotizzazione dell’organizzazione industriale, piattaformizzazione come nuova forma della fabbrica – cioè grazie all’egemonia dell’ideologia neoliberale, ma soprattutto grazie alle nuove tecnologie e alla digitalizzazione del vecchio taylorismo che esse permettono di realizzare»2.
Nel presente, il lato feticisticamente oscuro dell’intelligenza artificiale (IA), aldilà delle proiezioni distopiche che prevedono IA fuori controllo, che andranno a sostituire oltre che il lavoro (cosa auspicabile nel caso si tratti di un mero impiego, nel quale si prestino corpo e mente senza alcun coinvolgimento emozionale e vocazionale), anche gli stessi esseri umani, è quello in cui la forza lavoro rimane il lato occulto del capitalismo digitale. Quello nel quale le attività di data work, come prelevamento e scrematura dei dati, programmazione dei transformer che li organizzano e rinforzi per migliorare l’apprendimento degli algoritmi, tramite feedback umani, vengono spesso svolte da lavoratori del Sud globale, sfruttati economicamente e defraudati del loro surplus cognitivo, quello incorporato nelle macchine che essi addestrano per migliorarne le prestazioni. Insomma, anche la tecnologia della IA, e non poteva essere altrimenti, vista la sua sussunzione alla logica proprietaria e di sfruttamento capitalistica, concentra in sé, dalla produzione al consumo, un sistema di relazioni sociali e di potere asimmetriche. Quando non sia già in sé, a partire dal suo concepimento, lo strumento più potente e raffinato, escogitato dal sistema produttivo capitalistico, per innescare nuovi colossali cicli di espansione del valore.
Se la stima fatta da OpenIA, società produttrice di GPT-4, di una trasformazione o sostituzione dell’80% dei posti di lavoro che saranno interessati nel prossimo futuro dall’IA, la realtà del presente è la sostituzione di posti di lavoro inquadrati, con micro-lavori iper-precari, distribuiti in particolar modo nel Sud del pianeta. Antonio Casilli, autore di Schiavi del clic, scrive: «Alla domanda: “Dove viene prodotta l’intelligenza artificiale?”, oggi noi diamo una risposta originale: non nella Silicon Valley o in grandi centri tecnologici dei paesi del Nord. I dati, ingredienti fondamentali dell’IA, vengono prodotti nei paesi emergenti e in via di sviluppo. Foto, video e testi sono filtrati e arricchiti dai lavoratori delle piattaforme internazionali come la famigerata Mechanical Turk di Amazon, che li paga a cottimo per realizzare piccoli progetti online che durano appena qualche minuto: trascrivere, registrare, taggare, moderare, ecc. Ci sono anche altre grandi imprese quasi sconosciute come Appen o Telus, e piattaforme più piccole come la russa 2captcha e l’africana Sama. Nel gennaio scorso, Sama è stata oggetto di rivelazioni da parte della rivista Time, la quale ha scoperto che centinaia dei suoi micro-lavoratori in Kenya hanno “addestrato” ChatGpt […] La mappa globale che emerge dalle nostre ricerche attesta la costituzione di un vero e proprio esercito industriale composto principalmente da persone tra i 20 e i 30 anni (ma anche quarantenni e pensionati nei paesi del Nord). In alcuni paesi, la maggioranza è costituita da donne con figli a carico che accettano di essere pagate meno di due euro all’ora. Anche nel Sud globale, questi salari non sono sufficienti per una vita dignitosa. Il fenomeno è strettamente legato alla disoccupazione e all’economia informale. I micro-lavoratori hanno regolarmente un livello di istruzione superiore alla media del loro paese, ma non riescono ad accedere al mercato del lavoro e guadagnano realizzando “micro-task”, ovvero brevi progetti retribuiti pochi centesimi»3.
Lo stesso desiderio e la cooperazione sociale, fondamento dell’intelligenza collettiva (general intellect), che dal pensiero marxista, segnatamente quello “operaista”, erano intesi come terreni di soggettivazione antagonista al comando capitalista, vengono sussunti e plasmati da quest’ultimo, addestrando le piattaforme digitali e le più recenti tecnologie di IA, all’estrazione di valore. La società iperindustriale porta con sé una riorganizzazione del lavoro, in direzione di una sua parcellizzazione e autonomizzazione, tramite piattaforme digitali, che coordinano crowdworking e lavoretti digitali (gig works) e un abbattimento della frontiera che divideva l’uomo dalla macchina, in direzione di una forma di lavoro, il cyber-lavoro, nella quale essi risultano integrati, potenziati, misurati e monitorati. Nei magazzini della logistica di Amazon, i processi lavorativi vengono frammentati in micro-operazioni eso-strutturate, in modo tale da modellare e monitorare gesti, movimenti e sforzo nervoso degli operatori che vi lavorano.
Ci si sta avviando verso una macchinizzazione del vivente, la cui vita quotidiana è sempre più supportata da strumenti digitali, e una vivificazione della macchina, la quale svolge un numero sempre maggiore di attività che una volta appartenevano all’essere umano, in direzione di una soggettività macchinica. Un esoscheletro digitale potenzia le capacità della forza lavoro, penetrando contemporaneamente nella produzione, nei consumi, nella socialità e nella riproduzione. IoT, Big Data, realtà virtuale, IA, cloud e robotica evoluta «concorrono a formare ambienti che hanno in comune l’incorporamento di istruzioni digitali (algoritmi) e punti di connessione abilitanti il dialogo tra mondo fisico, umani, macchine, ridefinendo logiche organizzative e pratiche individuali e collettive, nel lavoro come nella più generale sfera sociale»4. Gli algoritmi stanno ormai alla base del mondo della produzione industriale, come della società nelle sue modalità di consumo e di relazione. Le macchine digitali al cui interno sono codificati, diventano altrettante scatole nere nelle quali sono cristallizzati asimmetrie di potere, che formattando abitudini e comportamenti degli individui, diventano strutture d’ordine della società.
Allo stesso tempo alcune ricerche condotte nel mondo della logistica e dei riders, testimoniano la presenza di eccedenze rispetto a una sussunzione algoritmica totalitaria del lavoro, le quali generano comportamenti reattivi nei confronti della piattaforma. Quest’ultimi però non vanno nella direzione di forme di agency che abbiano un qualche aspetto solidaristico e non giungono mai a produrre una resistenza all’ordine organizzativo algoritmico. L’ethos imprenditoriale neoliberistico, infatti, informa le condotte di questi lavoratori falsamente autonomi e autoorganizzati, ognuno dei quali è in competizione con l’altro per migliorare la propria posizione all’interno dei dispositivi di rating premiali, con il risultato di riprodurre una gerarchizzazione all’interno della piattaforma stessa. La quale, ricordiamolo, non è solo uno strumento di organizzazione del lavoro, ma un’ecosistema che incrocia domanda e offerta, articolato in un’ampia e diversificata suddivisione del lavoro. Di più: “le piattaforme digitali mediano ogni tipo di relazione sociale, economica e politica. Nell’esercitare il potere e nel plasmare tali mediazioni, le piattaforme hanno quindi un’enorme capacità di modellare le nostre vite e il mondo in cui viviamo”5.
Allo stesso tempo, di fronte alla parcellizzazione, precarizzazione e povertà salariale del lavoro, con modalità di erogazione di quest’ultimo, dettate da un paradigma industriale just-in-time, stiamo anche assistendo a un abbandono di massa del lavoro stesso. All’interno di un tale panorama sociale ed economico produttivo, viene anche da chiedersi quale sia l’impatto che le trasformazioni del lavoro, indotte dal capitalismo digitale, possono avere sui corpi e gli affetti e quali le possibili risultanti psichiche e relazionali.
Forse il fatto che algoritmi e IA rimangano ancorati ad uno statuto strumentale, senza assumere vesti oracolari o contribuire a generare sfruttamento economico, disarticolazione sociale, rendite di posizione, polarizzazione della conoscenza e del potere politico, potrebbe dipendere dal loro venire condivisi e collettivizzati a livello globale, dal loro essere open-source, dal considerare i big data come un bene comune non privatizzabile, nella direzione di un superamento della società automatica6 nella quale viviamo. Questo nel caso si voglia assumere la doppia valenza significativa che Stiegler assegna alla tecnica, nella sua veste di pharmakon, insieme veleno e possibile cura.
1 Titolo di un libro di Carlo Formenti, Felici e sfruttati. Capiralismo digitale ed eclissi del lavoro, EGEA, Milano 2011
2 Demichelis, L., Ma l’intelligenza artificiale, così com’è, è insostenibile, Agenda Digitale, 2023 https://www.agendadigitale.eu/cultura-digitale/lintelligenza-artificiale-e-ecologicamente-e-socialmente-insostenibi
le-ecco-perche/
3 Casilli, A., Intelligenza artificiale, l’esercito dei precari, il manifesto, 2023, https://ilmanifesto.it/intelligenza– artificiale-lesercito-dei-precari
4 Into the black box (a cura di), Capitalismo 4.0 Genealogia della rivoluzione digitale, Meltemi, Milano 2021, pp. 26-35
5 Graham M., prefazione a La geografia delle piattaforme digitali, FIRENZE UNIVERSITY PRESS, 2022
6 Stiegler, B., La società automatica 1. L’avvenire del lavoro, Meltemi, Milano 2019