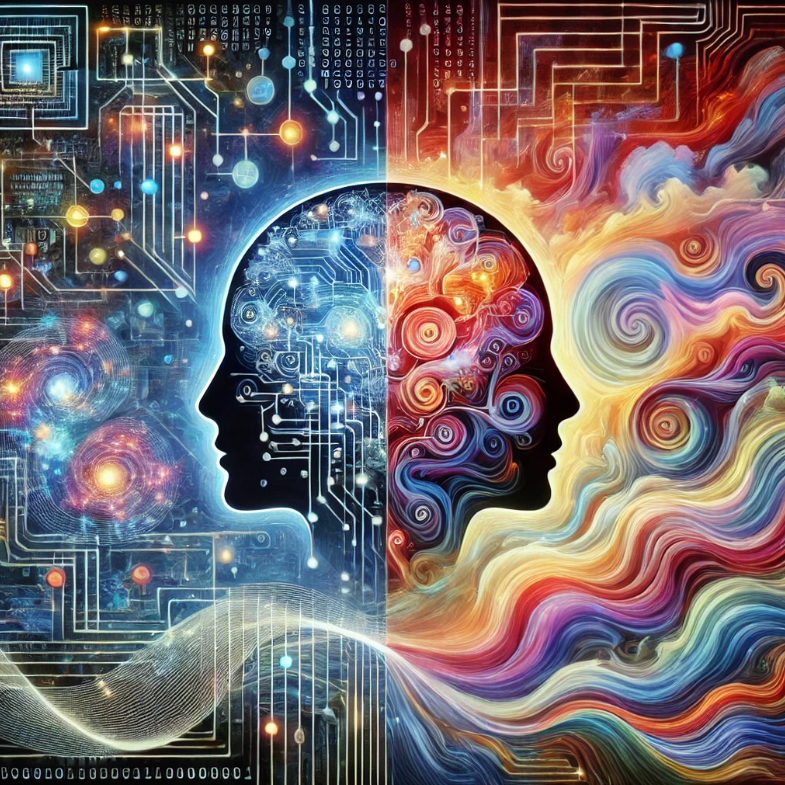Codice e contesto di vita
Se accogliamo una definizione polisemica di codice, o come una sequela di istruzioni, o come un insieme di leggi che disciplinano un determinato ambito, o complesso di regole di comportamento seguite in una determinata società, o sistema di simboli, lettere o numeri usati per trasmettere informazioni, potremmo proporre una definizione assai estesa di tecnica, come comprensiva di tutte le codificazioni strumentali, linguistiche, culturali che l’essere umano, fin dalla sua iniziale antropogenesi, è riuscito a collocare fuori di sé: dando loro cioè una forma oggettiva, impersonale e universale, che le rendesse disponibili, quanto al loro uso, a chiunque avesse la possibilità e il diritto di accedervi.
Ossia potremmo definire “tecnica” tutto ciò che comprende un ambiente esterno peculiarmente umano, fatto di manufatti, di lingue, di istituzioni, di ogni tipo di artificio, e come tale distinto dall’ambiente esterno geologico, climatico, animale e vegetale. La proposta che qui avanziamo è dunque che intendiamo per tecnica il depositarsi all’esterno dell’essere umano degli “universali” (universali di maggiore o minore estensione) se per universale intendiamo le invarianti del nostro esperire. Ovvero ciò che non fluisce nel trapassare costante del nostro tempo di vita, bensì ciò che in esso si ripete, divenendo per tale ripetersi, e fissarsi nell’autonomia della sua esteriorità non solo strumento, ma anche guida e orientamento del nostro vivere ed agire.
Fin dal lavorio sulle prime selci, fin dalla prima invenzione del linguaggio, fin dal cacciare e dividere prede nei gruppi dell’Homo sapiens, è “tecnica” tutto ciò che si carica della ripetizione e non si consuma nell’immediatezza di un’unica esperienza. Dunque non trascorre e non si perde senza continuità nel passato, nel fluire immemore di un tempo puntiforme e sempre rinnovato, ma si fa appunto memoria, consuetudine, legge, fino a fissarsi in una normativa che rende competenti e autorevoli coloro che vi accedono e sono abilitati a farne uso.
In questo senso si può dire che strutturalmente fin dalla origine dell’umanità tra esseri umani e tecnica, tra antropologia e tecnologia, s’è data compresenza, o meglio s’è data coalescenza e ibridazione. Una ibridazione che ha sempre viaggiato nei due sensi, perché come l’essere umano ha utilizzato il mondo degli artefatti, il mondo degli universali, facendosene proprio strumento e applicandoli agli eventi particolari e concreti del suo vivere, così il mondo degli artefatti, a muovere dalle sue legalità autonome di sistemi tecnici, ha plasmato l’essere umano, producendo effetti di selezione e specializzazione nella configurazione del suo corpo e della sua mente, di contro alla messa in ombra o in pausa di altre funzioni psico-corporee (1).
Si pensi, come esempio, al passaggio epocale che nel transito storico dalla cultura orale alla civiltà della scrittura ha subito la struttura della psiche, quando il sapere dall’essere trasmesso attraverso narrazione e recitazione, incluso il discorso ritmico dell’epos antico scandito secondo rime e moduli metrici, viene sostituito dalla scrittura, che implica quanto a uso della grafia un’utilizzazione della mente profondamente diversa da quella di un contesto culturale in cui la trasmissione delle informazioni avviene attraverso l’uso di suoni solo fonetici e la loro memorizzazione.
E’ stato del resto, e non a caso, proprio Platone, che si trovava alla fine di quel transito storico dalla cultura orale alla civiltà della scrittura, a trattare della bontà delle tecniche e della loro insostituibilità nel mantenimento e nello sviluppo della vita umana. Continuando la laicizzazione e valorizzazione delle tecniche compiuta nella Grecia del V°secolo dall’Illuminismo sofistico (2), Platone ha infatti stretto insieme divisione del lavoro, articolata attraverso le varie technai e la civiltà della polis, teorizzando che, appena l’essere umano esce da una condizione di minima autosussistenza, nessuno basta a sé medesimo riguardo al soddisfacimento delle proprie necessità ed assegna perciò la propria bisognosità al circuito della divisione dei lavori che è l’orizzonte più proprio della polis greca e della sua struttura materialisticamente più caratteristica.
Per altro che le tecniche poi non bastino, nello stesso discorso platonico (3), per assicurare la riproduzione della società umana, perché hanno bisogno di essere integrate e guidate da quella ulteriore ma particolare techne che è la techne politikè, la tecnica politica della direzione della polis, qui ora non interessa argomentare. Perché ciò che preme invece sottolineare è quanto per Platone la techne sia scienza degli universali, per nulla riducibile a una esperienza acquisita con la ripetizione e l’abitudine (quella che lui definisce mera empiria, empeiría).
Infatti ogni techne è tale per Platone in quanto il suo campo di azione è ben delimitato e differenziato dai campi delle altre technai, dove ogni oggetto, e ogni campo di realtà, possiede una sua intrinseca legalità, un suo ordine e una sua specifica destinazione d’uso, di cui dà conto l’idea, l’eidos, quale configurazione della struttura di ogni campo al meglio delle sue possibilità. E di tale connessione tra areté, da intendersi come virtù e valore di una cosa al meglio delle sue possibilità di azione, e il suo eidos, la sua legge e il suo modelli ideali, è appunto competente chi ne possiede e ne esercita la techne : ossia colui che, attraverso il sapere del logos e dell’ordine causale e metodologico che presiede quell’ambito specifico di realtà, ha la capacità di governarlo e produrlo secondo la sua vera, e non errata, funzione. La techne è quindi in Platone profondamente connessa all’episteme, alla scienza degli universali, giacchè il technikós, l’artigiano produce l’opera solo mirandone l’idea, ossia il modello che rende una cosa veramente tale, nella sua vera identità e nella sua vera struttura di relazioni (4).
Così, muovendoci all’interno di una interpretazione non contemplativa bensì pratico-operativa della filosofia platonica, una interpretazione che mitiga profondamente la trascendenza del mondo delle idee, ciò che ne deriva è una conferma di quanto una ibridazione costante tra motivazione irripetibile dell’atto di esistenza concreta e universalità depositata negli artefatti, ossia una coalescenza di scambio ininterrotto tra contesto particolare di vita e codice, tra individualità dell’esperire e universalità delle norme, sia sempre all’opera in una antropologia che non può non essere intrinsecamente una antropologia tecnologica.
A ben considerare tale continuità tra antropologia e mondo delle tecniche, tra contesto vivente e codice, non è venuta del resto meno neppure con la grande rivoluzione scientifica del ‘600, con la matematizzazione della natura. Il passaggio dal mondo del pressappoco all’universo della precisione, per dirla con il titolo del classico libro di Alexandre Koyrè (5), cioè da una raffigurazione qualitativa fondata sui cinque elementi della natura aristotelico-scolastica (terra, acqua, aria, fuoco, etere) a una concezione quantitativo-galileiana della natura, continua a descrivere attraverso l’applicazione dell’algebra alla geometria, corpi che descrivono traiettorie, curve, parabole, ellissi nella continuità di movimenti nello spazio e nel tempo. Quanto a continuità tra mondo della vita materiale e mondo dell’idealità tecnica basti inoltre pensare che il primo principio fondamentale della fisica galileiana, il principio di inerzia (“un corpo rimane nel suo stato di moto rettilineo uniforme finché non viene ostacolato da una forza esterna”), è un principio certamente solo ideale, perché non lo si trova mai nella realtà, ma è pure in continuità con la realtà: il suo essere un limite ideale, estremo, ci consente di misurare tutti i movimenti gravitazionali e di attrito che invece nella realtà pongono vincoli concreti ed esperibili a quella condizione ideale.
Tutto ciò per dire che l’uso della matematica come codice fondamentale per descrivere i fenomeni naturali a partire dalla rivoluzione del ‘600 non ha trascinato di necessità il mondo matematizzato in un altrove lontano dall’agire del nostro corpo biologico nel mondo ambiente con la sua costruzione di spazio e di tempo che ne deriva. In tal senso è necessario ricordare quanto teorizza Husserl nell’Origine della geometria mostrando come le essenze ideali-esatte della geometria abbiano avuto origine a partire da atti pratici di azione del mondo della vita, attraverso la progressiva elaborazione della forma sensibile in pura forma-limite, dove appunto il concetto di limite è fondamentale per la continuità tra ideale e reale (6).
Ma pensiamo anche all’opera di epistemologo e di storico della matematica dell’italiano Giuseppe Longo e alla sua opposizione critica all’estromissione del soggetto senziente ed esperiente dal mondo della scienza. E di come invece quanto solo una memoria legata all’emozione, specificamente come quella propria dell’organismo umano, sia in grado di trovare ed estrarre invarianti, cioè universali, a partire dalle sue necessità di orientamento, di protensione e anticipazione del futuro nel suo relazionarsi costante con il mondo-ambiente (7).
Giacché in questo gioco costante che si dà tra contesto e codice, tra mondo della vita e mondo degli universali, è sempre il nostro corpo, nella continuità del suo vivere e del suo agire, che appare rimanere il luogo originario ed ultimo del senso: di un “sentire” cioè che, nella sua anteriorità biologica, si fa sempre criterio ultimo di quali significati, di quali codici, di quali tecnologie far uso per accrescere e non diminuire la propria potenza di vita. Ovvero torna a dirsi, è l’intensità dei nostri vissuti emozionali che dà forma e sedimentazione alla memoria e, a partire da questa, all’azione selettiva e protensiva di un organismo vivente.
Ma affermare tutto ciò significa anche definire per un certo verso l’analogico, quale orizzonte generale e insuperato degli oggetti tecnologici che, fino alla rivoluzione digitale, hanno caratterizzato la relazione tra bisognosità e contesto storico-particolare di vita umana da un lato e dall’altro codificazione degli universali tecnico-culturali necessari a quella riproduzione vitale. Dove appunto analogico si riferisce a strumenti, sistemi o dispositivi che mantengono, sia pure in una misura al limite, un qualche grado di continuità, di analogia appunto, con l’organizzazione biologico-psichica dell’essere vivente umano, e dove quindi analogico indica appunto una qualche continuità di funzionamento e di simbiosi tra organismi umani e organismi tecnici non umani.
Orbene è proprio quanto detto fin qui che ci consente, a mio avviso, di porre in rilievo quanto e come la nuova tecnologia digitale abbia inaugurato per la prima volta nella storia della cultura umana una codificazione che è assai lontana dalla corporeità, o per dire più precisamente, che è del tutto decorporeizzata.
Basti rifarsi in tal senso alla distinzione tra la numerazione a base decimale, propria dell’analogico, e la numerazione a base binaria propria del digitale. Il sistema decimale, che si è sviluppato a partire dal numero di dita che gli esseri umani hanno a disposizione, è strettamente legato alla fisiologia umana e come tale s’è facilmente universalizzato, nel commercio, nella matematica, nella vita quotidiana, indipendentemente da lingue, culture e identità nazionali. Le dieci cifre disponibili per rappresentare i numeri nella posizione delle unità, delle decine, delle centinaia, etc., consente di misurare e rendere immediatamente visibile la distanza tra due punti, includendo nella continuità di un’unica cifra l’immagine di quella distanza, con tutte le sue possibili variazioni. Invece una misurazione basata sull’alternanza di 0 e 1, acceso/spento, sì e no, ammette solo una stringa di cifre alternate e separate, senza possibilità di valori intermedi tra di esse. Ed è proprio questa differenza ontologica tra il continuo e il discontinuo, tra i ritmi ininterrotti della corporeità (8) e la misurazione binaria basata sull’alternanza del Sì e del No che rompe, io credo, l’ibridazione tra contesto e codice, dando la possibilità al codice di autonomizzarsi in un universale che si fa astratto ed automatico.
E’ proprio cioè tale rimozione della corporeità che apre l’epoca dell’informazione in quanto raccolta ed elaborazioni di dati, privi di rumore, di ambiguità, di polisemia e perciò quantificabili secondo una matematizzazione certa e priva di errori.
Informazione e interpretazione
Ma è appunto tale statuto di un significato, di un messaggio, senza rumori e senza vaghezza, che ben esprime quanto la logica dell’informazione sia lontana dalla logica dell’emozione. Perché come ci insegna la tradizione psicoanalitica, da Freud a Jung, passando per postfreudiani come Klein e Bion, fino a giungere a i giorni nostri, la struttura dell’emozione appare essere costituita da una strutturale ambivalenza, dall’essere abitata cioè da un nesso intrinseco di opposizione per il quale, ogni oggetto di amore, proprio nel suo essere termine di desiderio, è anche oggetto di invidia e di odio.
Per chi frequenta assai meno i dualismi e le scissure di Jacques Lacan, profondamente ispirate alla differenza e ai salti ontologici di Martin Heidegger (9), e assai più la dialettica freudiana e junghiana, intesa appunto come una teoria della pulsione che vive sia dell’Eros della costruzione di legami sia del Thanatos dell’invidia e della distruzione, risulta ben chiaro che sia proprio l’ambivalenza e la dubbiosità a costruire un impasto emozionale, da sciogliersi o meno ogni volta da parte del soggetto in questione secondo l’affetto più forte e di maggiore intensità.
Ma questo significa che l’informazione depositata ed elaborata nei dispositivi digitali tanto più è univoca e indubbia quanto più è priva di interpretazione, cioè quanto più è slegata da quel nostro corpo emozionale che appunto attraverso i vertici del nostro sentire, seleziona, organizza e interpreta le informazioni e gli stimoli che ci giungono dal mondo-ambiente
Ed è singolare quanto curioso, almeno per lo storico della filosofia, che il dispositivo tecnologico a noi più contemporaneo e innovativo, per tale sua struttura costituzionale dell’alternanza tra il Sì e il No, non possa non richiamare l’inizio della storia della filosofia occidentale quando il poema di Parmenide obbligava a pensare il mondo attraverso l’esclusione manichea dell’Essere e del Non-Essere. Quando cioè una concezione ancora primitiva e magico-rituale del linguaggio costringeva a rendere impossibile concepire il divenire e a serrare la realtà nell’identità indifferenziata e monistica del solo Essere, pensabile e possibile solo perché contrapposta radicalmente al Non Essere (10). Tanto che tutto lo sviluppo della filosofia greca successiva fino a Platone e ad Aristotele può essere visto come un progressivo affrancamento da quella metafisica aporetica ed esiziale di una identità costruita sull’esclusione di ogni differenza e di ogni particolarità. contro la differenza senza le differenze e i particolari.
Ma, ritornando al nostro tema, io credo che in questo tempo di profondissima variazione tecnologica, nell’orizzonte della progressiva sostituzione dell’analogico con il digitale, vada sottolineata con forza la differenza che si dà tra informazione e interpretazione. Informazione non è interpretazione, perchè l’interpretazione, sia in ambito biologico che in ambito storico-sociale, muove sempre dagli interessi di riproduzione della vita da parte di un organismo vivente, individuale o collettivo, collocato i uno spazio tridimensionale e in uno specifico contesto culturale. Mentre l’informazione (digitale) corrisponde a una stringa di simboli alfanumerici disposti secondo un’unica dimensione, priva di corporeità e di spazio tridimensionale.
Del resto, si potrebbe aggiungere che proprio la differenza tra informazione e interpretazione, teorizzata in tal modo, consente di chiarire ancor meglio la differenza che cade tra “significato” e “senso”. L’informazione infatti, per la sua codificazione, è ciò che può essere universalizzata e resa accessibile a tutti, e in quanto tale ha un significato, un contenuto accolto e riconosciuto da una intera comunità. Mentre il senso è ciò che definisce l’applicazione, l’uso, la destinazione privata di un significato e che, essendo generato dal corpo emozionale, da un corpo vivente, è il luogo del sentire che appunto dà il senso come direzione al percorso e al progetto di vita, non comparabile con altri, di ogni individualità.
E’ dalla distinzione tra informazione e interpretazione, così come da quella tra significato e senso, che dobbiamo ripartire dunque per rifiutare la nuova metafisica che va sotto il nome di teoria dell’infosfera, ossia l’ideologia che pretende di teorizzare che la materia non sia altro che informazione, che i nostri corpi e le nostre menti, nei loro componenti ultimi, non siano costituiti da altro che da informazioni, che il mondo sia un massive information process. Si ricordi in tal senso quanto scriveva nel 1990 il fisico americano John A. Wheeler: «Tutto è bit [It from bit]. O per dirlo in altri termini, ogni cosa – ogni particella, ogni campo di forza, perfino lo stesso continuum spazio-temporale – deriva la sua funzione, il suo significato e la sua intera esistenza, seppure in taluni contesti indirettamente, dall’insieme di risposte fornite alle domande sì-o-no, di scelte binarie, di bit. ‘Tutto è bit’ simboleggia l’idea che ogni oggetto del mondo fisico ha alla base – una base in molti casi veramente profonda – una fonte e una spiegazione immateriale; ciò che definiamo realtà emerge in ultima analisi dalla formulazione di domande sì-no e dalla registrazione dell’insieme delle risposte evocate; in sintesi, tutti gli enti fisici sono in origine teoreticamente informazionali e questo è un Universo partecipativo» (11). Con la conseguenza che deriva da tale metafisica, da tale ontologia, dell’informazione che lo stesso essere umano venga concepito come un ente informazionale e che si ritenga che anche il cervello umano operi conformemente alla processualità di un computer.
La prospettiva critica, che sta a base di questo mio intervento, muove invece dal concetto di una “mente incarnata”, cioè di una mente che ha ad oggetto primario della sua attività la cura e la riproduzione del corpo biologico (o corpo interno) dell’essere umano attraverso la mediazione con la realtà del suo corpo sociale (o corpo esterno). Ossia una prospettiva di ispirazione materialistica, insieme biologica e storica, che rimette in discussione anche la unilateralità solo sociologica della celebra affermazione di Karl Marx, contenuta nelle Tesi su Feuerbach, che la “essenza umana sia l’insieme dei rapporti sociali” (12).
Rispetto a una valorizzazione di una relazionalità solo sociale e storica, che ha costituito il limite di fondo, a mio avviso, di una antropologia come quella marxiana, ma anche di buona parte delle cosidette scienze umane, estenuate dal monismo dell’intersoggettività e centrate su un relazionalità solo esteriore, è la psicoanalisi infatti, nella complessità della sua tradizione, che ci dice e ci insegna che la specificità dell’esistenza umana rispetto alle altre specie del mondo animale e naturale consiste nell’essere caratterizzata da due dimensioni fondamentali: l’asse verticale dell’interiorità su cui si costruisce il rapporto tra corpo e mente, tra coscienza e inconscio, tra affetto e concetto, con tutte le possibili integrazioni ma anche le possibili scissioni e gradi di repressione e censure che possono nascere da questa costituzione bina dell’umano, e l’asse orizzontale, di carattere sociale, costituito dall’insieme di tutte le relazioni che quell’individualità può stringere ed avere con il contesto storico-collettivo in cui vive (13).
Riuscire a sintetizzare e portare a coerenza questi due assi, la materialità e animalità del corpo biologico e la trama delle relazioni culturali e sociali, rappresenta io credo il compito più difficile della vita umana e della sua riproduzione. Ed appunto di questa compresenza dei due assi, eterogenei tra loro, con una logica d’ognuno non riducibile a quella dell’altro, vive la peculiarità e la drammaticità dell’essere vivente umano rispetto alle altre specie viventi. Di essere cioè un “centauro” che ha il compito permanente di condurre a coerenza insieme corpo animale e mente angelica. E quindi di praticare il conatus, lo sforzo costante di non cadere in quel dualismo cartesiano di res extensa e di res cogitans, di concetto ed affetto, che costituisce il rischio trascendentale, permanente, della nostra soggettività (14).
Ma proprio una antropologia fondata sulle due assi rivela che nell’essere umano opera una conoscenza non codificata che ha per contenuto i sentimenti di benessere o di malessere, le emozioni di potenza o d’impotenza di vita, di laetitia o di tristitia, avrebbe detto lo Spinoza dell’Etica, che nascono dalla corporeità di ognuno con la sua individuale storia generazionale e filogenetica e con una costituzione emozionale, con una ontogenesi assolutamente singolare, non eguagliabile a quella di un nessun altro essere umano. E che, nello stesso tempo, opera una conoscenza codificata che, attraverso istituzioni esterne, come riti e istituzioni, pratiche economiche e del lavoro, ideologie e credenze collettive, libri, biblioteche e artefatti digitali, caratterizza l’ambiente socio-culturale in cui quella singolarità vive. Dove cultura e tecniche formano l’ambito del conoscere che per principio è codificato e che si costruisce appunto attraverso simboli, mappe e codici che provano a definire regolarità e invarianze dell’esperienza umana e a facilitarne in tal modo la riproduzione sempre varia e incidentale di vita.
Le due conoscenze, quella non codificata e quella codificata, intrecciano le due dimensioni che strutturano in modo tendenzialmente unitario, ma anche conflittuale, l’essere umano: l’appartenenza alla specie biologica, con tutta la storicità dell’evoluzione anche familiare e generazionale che ogni fenotipo eredita e porta nel suo corpo, e l’appartenenza, nello stesso tempo, a una cultura socialmente e storicamente determinata. Per tale intreccio la tecnica non è qualcosa di esteriore, di aggiunto, alla costituzione dell’essere umano. Essa è fin dall’inizio consustanziale all’essere umano, com’è accaduto ad esempio con i tre grandi passaggi della storia dell’umanità, con l’invenzione del linguaggio e poi della scrittura alfabetica, in seguito con la fine della scrittura amanuense e la diffusione della stampa a caratteri mobili, ed oggi con l’invenzione della scrittura digitale.
La mia tesi è dunque che il senso del vivere, l’intenzione del nostro agire, l’interpretazione, cioè l’insieme di valori di base attraverso cui filtriamo e dirigiamo il nostro interesse sul mondo, non appartengono e non emergono dalla conoscenza codificata, dagli enormi depositi di informazioni codificati e trasmessi attraverso simboli, quali che essi siano, ma nascono da un corpo in situazione, cioè da un vissuto organico e dal suo conoscere attraverso il sentire. Questo significa che il senso, che è sempre proprio di una singolarità vivente, attinge costantemente al codice universale, al patrimonio del mondo delle tecniche, senza il quale non ci sarebbe possibilità di metabolismo e scambio con il mondo-ambiente, ma solo a patto di ricondurre quell’universale codificato e valido per tutti, al contesto e al giudizio della propria singolarità vitale, unica e irripetibile rispetto al complesso delle vite degli altri.
Un’intelligenza statistica
Ma tale circolo dall’interpretazione all’informazione e viceversa, tale transito dall’intenzione non codificabile di una singolarità vivente agli universali della conoscenza codificata e viceversa, può avvenire solo in condizioni di vita individuale e di istituzioni sociali profondamente armoniche tra loro, dove non vi siano impedimenti e fratture, scissioni, censure e opposizioni, tra i percorsi dei due assi nel loro possibile dialogare tra loro.
Invece oggi, con le tecnologie digitali, accade la possibilità di un farsi autonomo della tecnica, di un suo separarsi ed astrarsi, fino a giungere alla pretesa di proporsi come una tecnostruttura capace di governare e regolare attraverso i suoi algoritmi la vita umana, organizzandola e plasmandola secondo il modello di un vero e proprio human engineering.
Su tale ipostatizzazione della tecnica digitale, su tale capovolgimento del nesso di antropologia e tecnologia agiscono, a mio avviso due cause fondamentali. Una di carattere semiotico, già accennata, che ha a che fare con la natura specifica del codice e dei segni usati nella transizione tecnologica che oggi ci attraversa, e un’altra di carattere invece più propriamente economico- sociale, legato alle proprietà strutturali e invarianti della economia capitalistica. La prima questione è legata, come si diceva, alla differenza profonda che si dà tra la semiotica di un codice analogico e la semiotica di un codice digitale. Come abbiamo visto, nei codici che si basano su un funzionamento di tipo analogico, come il linguaggio e la scrittura alfabetica, rimane un qualche legame di continuità con la base materiale, come accade con la fotografia analogica dove c’è uno scambio tra la composizione fisico-chimica della pellicola e la luce che investe il soggetto fotografato. Mentre nella codificazione digitale la smaterializzazione della realtà originaria è pressocchè totale con la sua traduzione in dati numerici.
Tutto ciò può condurre alla falsa credenza che la strumentalità operativa di un codice, con le sue universalizzazioni selettive e semplificative, che di ogni codice rimangono comunque la caratteristica, sia invece la realtà medesima e che dunque il mondo non sia altro che un mondo fatto di numeri e algoritmi, costituito da punti discreti, da particelle elementari semplici, da bit, che possono essere assemblati, coordinati e calcolati. Così se già la svolta linguistica all’inizio del ‘900 aveva preteso di dire che l’Essere è null’altro che linguaggio (si pensi in tal senso all’opera di Martin Heiddegger e poi a quella in ambito psicoanalitico di Jacques Lacan) questa nuova metafisica, che teorizza i codici alfanumerici costituire la struttura stessa della realtà, appare essere una specificazione della prima, affermando che l’ Essere è null’altro che informazione e che conseguentemente la stessa mente umana può e deve essere concepita come un dispositivo che accoglie anch’esso informazioni (inputs), per elaborarle al fine di produrre outputs congruenti e adeguati al problema che di volta in volta interroga il soggetto umano in questione.
Ma la metafisica in genere ha sempre prodotto una pessima antropologia. E infatti, fecondato e legittimato dalla metafisica e dall’ideologia della cosidetta “infosfera”, secondo la quale ogni luogo della vita e della realtà sarebbe strutturato e regolato da informazioni, si sta assistendo oggi, soprattutto in ambito scolastico-educativo, non ad una ibridazione bensì ad una colonizzazione dell’umano da parte di dispositivi digitali (15), con l’effetto di generare a mio avviso una drammatica superficializzazione ed atrofia della mente delle giovani generazioni.
Ma quando l’informazione prevale sull’interpretazione le capacità della mente si riducono in modo estremamente impoverente. Si consideri in tal senso che, ad esempio, un’applicazione dell’Intelligenza artificiale come ChatGBT realizza indubbiamente prestazioni assai utili, che possono apparire anche sorprendenti, ma che le sue risposte nascono da informazioni elaborate solo secondo una media statistica e probabilistica. Ossia ChatGBT riesce a lavorare su un enorme corpus di testi provenienti da libri, articoli, siti web ed altre fonti di dati testuali ed associando parole e frasi secondo la connessione di significato la più alta probabile, produce, secondo una media statistica, una informazione coerente e fluida dal punto di vista grammaticale e sintattico. Il programma è cioè in grado di predire e anticipare una parola o una frase successiva in base al legame maggiormente ricorrente con le parole e le frasi immesse come inputs e già depositate nella sua memoria, per cui quanto più si allarga il suo database, il suo campo di informazioni immagazzinate, tanto più esso migliora la sua capacità di connessione e di anticipazione. Per cui è indubbio che l’intelligenza artificiale produca attraverso ChatGBT la meraviglia di un sapere che si può estendere, pressocché istantaneamente, ad ogni campo dell’esperienza e della cultura umana. Ma con la consapevolezza critica, noi sottolineiamo, che le risposte generate dal programma corrispondono a sintesi che, costruite secondo l’operare di una media, non possono che offrire una esposizione, certo oggettiva, ma generica e non approfondita del contenuto trattato.
Ma appunto il modo di pensare di una macchina non può essere altro che impersonale e imparziale. Diversamente dall’essere umano, la macchina non può avere mai uno sguardo incarnato e di parte, legato al progetto e all’interesse di vita proprio di ogni soggettività individuale, bensì deve di necessità dar conto solo della medietà probabilistica delle tesi depositate ed accumulate da tutti gli sguardi, tutti gli autori e tutte le fonti che hanno trattato di un certo argomento.
Da questo punto di vista l’Intelligenza Artificiale può sicuramente allargare e produrre nuova conoscenza nell’ambito delle scienze naturali, per tutto ciò che è legato alla quantificazione e alla numerazione. Data l’enorme quantità di dati in grado di elaborare, può identificare infatti relazioni e combinazioni che sarebbe assai difficile da rilevare con metodi tradizionali, con una capacità di ricerca particolarmente utile in campi come la biologia, la fisica, le scienze ecologiche ed ambientali, le scienze della Terra. Può rilevare attraverso i suoi algoritmi automatici connessioni tra trasformazioni dei contesti di vita e malattie, approfondire conoscenze di molecole e di geni, migliorare il grado e la qualità di sperimentazione nei laboratori, catalogare e identificare in modo assai più ampio e preciso specie di piante, animali e strutture geologiche, sviluppare un enorme automazione nei processi produttivi di beni e di servizi. Per dire solo alcune delle applicazioni e dell’ampliamento di conoscenza che nelle scienze del numero – oltre che di produttività economica – potrà realizzare l’Intelligenza Artificiale.
Mentre a mio parere da parte degli algoritmi automatici non ci può essere produzione di conoscenza nelle scienze dei valori, nelle scienze come si diceva una volta dello spirito, che attengono cioè alle scelte umane, individuali e collettive, tra ciò che può e deve essere e ciò che non deve essere. Perché a fondamento di questo ambito del sapere e del conoscere si dà, nella mia visione, il criterio dell’affetto e dell’emozione, principio ultimo appunto della scelta tra il bene e il male. Laddove le macchine calcolanti, fatte di aggregati di pezzi elettromeccanici, di hardwares fisici, di softwares costruiti su linguaggi alfanumerici, non posseggono né affetti né emozioni.
Tanto che, seguendo anche qui l’indicazione critica di Giuseppe Longo, credo che non dobbiamo più dare legittimità all’espressione “intelligenza artificiale”. Dobbiamo parlare di macchine algoritmiche, di macchine numeriche, di automi computazionali, ma non di macchine con coscienza e intelligenza. La macchina computazionale lavora attraverso degli algoritmi su una enorme quantità di dati, che precedentemente sono stati raccolti, immagazzinati e indicizzati in linguaggio numerico da esseri umani. Con un procedimento statistico la macchina ricerca le invarianti più significative di certi contenuti e attraverso la ricerca di ciò che è più probabile, di ciò che sta nella media, offre immagini, suoni, linguaggi e testi. Ma stoccare, accumulare dati e trarne medie statistiche non significa pensare.
Senza l’unione di Kant con Hegel. La scuola formatrice di “vuoti a perdere”
E’ la tradizione della psicoanalisi che, pur nella molteplicità dei suoi indirizzi, ormai da più di un secolo ci insegna che il pensiero umano si genera e si sviluppa perché elabora emozioni prima che informazioni. Nella specificità del paradigma pulsionale freudiano, e nella distinzione tra processo primario e processo secondario della psiche, il movente del pensare è infatti il soddisfacimento pulsionale, ossia nella metafora del linguaggio di Spinoza la condizione generale di benessere e di laetitia, senza estremizzazioni ed asimmetrie, del corpo organico. In tale quadro il pensiero nasce dalla necessità di mediare mondo emozionale e condizioni di soddisfacimento offerte dal mondo esterno, in una necessaria sospensione dell’urgenza pulsionale, senza il cui raffreddamento ci sarebbe solo invasività ed esplosività dell’istanza corporea nell’operare della mente. E’ cioè una relazione intrinseca e concreta con il nostro corpo che accende il funzionamento mentale e tale relazione consiste appunto in una capacità di lavoro – di sospensione ed elaborazione dei livelli emozionali profondi – che consenta la nascita del pensiero e l’accoglimento del principio di realtà.
Ma non basta mettere a tema l’asse “verticale” dell’essere umano. Non basta cioè limitarsi alla grandezza del genio di Kant, il quale per primo è giunto a teorizzare la natura bina della soggettività, argomentando del suo strutturarsi su due facoltà profondamente eterogenee tra lore: funzionanti cioè con una logica, con un modo di agire profondamente diverso, ma pure consustanziali e compresenti nella sintesi del loro operare. Perché la Critica della ragion pura di Kant è nata proprio dalla denuncia di una visione monistica della soggettività concepita dalle precedenti tradizioni filosofiche, rispettivamente, della tradizione empiristica da un lato e di quella razionalistica dall’altro: secondo le quali l’essere umano o è solo la verità della sensazione, riducendosi il pensiero concettuale solo a un riflesso e a un’ombra di quest’ultima, o, viceversa è solo intelletto e ragione, essendo la sensazione solo il luogo del falso e dell’apparenza. Ed appunto è stato Kant contro il monismo filosofico e gnoseologico della filosofia che lo ha preceduto a riconoscere per primo e a teorizzare con forza la natura bina, duale dell’essere umano, nella stratificazione delle due facoltà della “sensibilità” e dell’“intelletto” (16).
Oltre alla verticalità e al dualismo della mente kantiana abbiamo infatti bisogno della dialetticità “orizzontale” della mente hegeliana e del suo nesso di riconoscimento tra soggetto ed altro soggetto. E’ Wilfred Bion, com’è noto, che ci ha insegnato che la mente umana non nasce come apparato per pensare adeguatamente se non in quanto mente al quadrato. Cioè come mente contenuta nella sua bisognosità pulsionale da un’altra mente che sia in grado di riconoscerne e individuarne le richieste emozionali e di restituirgliele mitigate e tollerabili, in modo tale che alla prima, accada di riuscire a entrare in un accoglimento adeguato del proprio corpo. Altrimenti senza la funzione mediatrice di tale alterità capace dicura e di maternage, la prima mente non nasce a sé medesima: come capacità di percepire ed elaborare le proprie emozioni, che, nella loro minacciosa e perentoria richiesta di immediatezza, si trovano invece ad essere espulse e proiettate al di fuori della soggettività in questione alla pari di “cose-in-sé”, per tornare al linguaggio di Kant, ossia come pensieri che non possono essere accolti e pensati, perché carichi di invasiva negatività e distruttività (17).
Senza questa compenetrazione di asse verticale e asse orizzontale nasce una mente solo esteriore a sè stessa, perché priva di un radicamento personale dentro il suo corpo, e, in tale astrazione strutturale, mente che si compone volgendosi solo verso l’esteriore, da cui attingere senso e significato, direzione di vita e valori. Nasce cioè una mente capace di formulare solo pensieri astratti, simbiotici e gruppali, che proprio per tali concetti privi di affetti, risulta essere affetta da un profondo senso di precarietà e di indeterminatezza. Insomma una mente pronta e disposta ad essere del tutto “informata” e per nulla “emozionata”.
Ora uno degli aspetti più significativi della nostra contemporaneità – e che ne costituisce una delle svolte storiche più drammatiche e cariche di un futuro regressivo – è che la possibile patologia della mente nella sua genesi e formazione, individuale e infantile, che abbiamo appena descritto secondo il modello bioniano, oggi stia diventando una patologia di massa, una patologia collettiva che contagia la nostra gioventù nell’intero percorso della sua formazione scolastica e universitaria. Vale a dire che sta venendo meno, almeno nel nostro paese, l’istituzione della scuola pubblica (inclusa l’Università) quale base insostituibile della democrazia, in quanto istituzione culturale capace di far uscire dal percorso scolastico una cittadinanza futura costituita da soggettività, dotata di un pur minimo grado di autonomia e di consapevolezza critica.
Pseudodemocratici di una cosidetta sinistra, abbacinati dalla loro conversione dallo stalinismo democratico all’accettazione di un neoliberismo senza residui, hanno non a caso, per farsi accettare come nuova classe dirigente, cominciato a smantellare dalla fine degli anni ’80 la nostra Scuola e la nostra Università, cambiandone radicalmente natura e finalità. Facendone cioè non una istituzione finalizzata alla cittadinanza bensì una introduzione/anticipazione del mondo del lavoro e della produzione economica. Hanno sostituito infatti il sapere come conoscenza dei valori e delle tradizioni storiche, letterarie e scientifiche fondamentali con quello di una scuola del saper-fare, del sapere utile a risolvere problemi, o come viene detto scuola delle competenze già pronte per spendibili su un prossimo mercato del lavoro.
Questa scuola del pragmatismo, dopo la sciagurata riduzione dell’Università a liceo realizzata attraverso la riforma del 3 + 2, vedrà ben presto, a mio avviso, la riduzione della stessa scuola superiore a soli quattro anni, secondo quanto già iniziato a sperimentare, e soprattutto una digitalizzazione estrema con una diffusione amplissima delle nuove tecnologie. L’Intelligenza artificiale sarà infatti fondamentale nella riduzione progressiva della lezione frontale e per un percorso formativo fatto sempre più di materiale didattico programmato e preregistrato, con verifiche e controlli automatici. Ma soprattutto la tecnologia digitale sarà molto utile per una didattica che vede spegnersi la necessità di grandi sintesi storico-culturali, perché ciò che vale è una logica indirizzata alla problematicità delimitata e particolare e un’acquisizione di “competenze”, utilizzabile, senza trama di discontinuità, nel mondo del lavoro. Con la conseguenza che verrà sempre meno valorizzato il sapere storico, quale apprendimento delle diverse forme di civiltà e di valori elaborate dalla comunità umana nel corso della sua evoluzione, di contro a una sollecitazione pragmatica concentrata sul presente. E tanto più si ridurrà conseguentemente quell’orizzonte di cultura umanistica che maggiormente appartiene alla nostra tradizione culturale ed educativa, per essere omologati, a motivo di una esterofilia semplificatrice e subalterna, al paradigma tipicamente anglosassone di una scuola appunto di competenze volte a prefigurare una identità già professionale e lavorativa (18).
Lo sviluppo di una tipologia individualistica di personalità sarà caratteristica di questo tipo di scuola, per il venir sempre meno della dimensione del collettivo di classe, quale contenitore di adolescenti che attraverso la medesima età e una comune esperienza di apprendimento provano a creare, con la mediazione dei loro docenti, delle loro diversità una comunità. Sarà cioè una scuola all’americana, dove non si muovono più i professori, ma si muovono gli studenti. In quanto il docente rimane fisso nella “sua” aula, mentre gli studenti entrano ed escono secondo la particolarità dei loro individuali piani di studio. E anche qui per questa scuola della frequentazione individuale, che vedrà drasticamente ridotta la comunicazione orizzontale del gruppo classe, sarà utilissima l’Intelligenza artificiale per gestire, nella rapporto verticale docente-discente, l’organizzazione del corso, la distribuzione dei materiali didattici, la flessibilità e personalizzazione dell’apprendimento attraverso l’accesso da remoto secondo ritmi di studio del tutto privati e infine l’uso di algoritmi che suggeriscano valutazioni in base ai risultati, non solo per studenti ma anche per professori.
La mia opinione è dunque che nel contesto di una Scuola e di una Università, come quelle attuali, ispirate e organizzate sempre più secondo una finalità pragmatista e neoliberista, l’applicazione e l’ampliamento dell’uso delle nuove tecnologie dell’informazione e dell’Intelligenza artificiale non potrà che andare, non nel verso dell’ibridazione dell’essere umano con la tecnica, bensì in quello della colonizzazione e, conseguentemente di una vera e propria catastrofe del mentale. Nel senso che potremmo assistere a una generalizzazione di una mente esteriore che non riesce più ad accedere a un pensiero che sia, oltre che relazione con il mondo, anche e in primo luogo coscienza e simbolizzazione della propria emotività.
Rispetto a tale quadro di un possibile e prossimo futuro l’utopia ci invita a dire che solo una psicoanalisi generalizzata, solo una “psicoanalisi per tutti”, potrebbe prendersi cura di questa patologia di massa che affetta sempre più la nostra gioventù e la costringe a “soffrire d’indeterminatezza”, cioè dell’incapacità di radicarsi nell’affetto e di maturare un proprio personale e idiosincratico progetto di vita. E che questa utopia di una psicoanalisi, che esce dallo spazio privato dei suoi studi, e si fa modalità relazionale collettiva potrebbe trovare il suo luogo proprio e solo in una Scuola/Università che attraverso una erotizzazione umanistica riuscisse a ricollocare la tecnologia dall’estremismo di una colonizzazione all’equilibrio di una integrazione.
Per altro guardiamo noi tutti alle meraviglie di queste macchine digitali che stanno rivoluzionando il nostro modi di vivere e che forse per la prima volta offrono all’umanità la possibilità di integrarsi e di comunicare con sé medesima, e con la propria memoria, in un modo globale, al di là di differenze etniche e di barriere geografiche e culturali. Guardiamo cioè noi tutti, lontani da romanticismi e da tecnofobie regressive, alle possibilità delle nuove tecnologie di accompagnarci ed introdurci in un più radicale umanesimo. Ma perché questo possa mai accadere c’è necessità, a mio avviso, di una popolarizzazione e istituzionalizzazione della cultura psicoanalitica ai suoi livelli più elevati e rigorosi. Ossia che il pensiero sociale, politico, istituzionale, faccia proprie le modalità psicoanalitiche della produzione di soggettività, individuale e collettiva, e che la stessa psicoanalisi, senza rinunciare alla sua pratica più legittimamente privata, abbia il coraggio di uscire fuori di sé e fecondare una nuova immagine del mondo, una nuova filosofia. Solo in tal modo potremo generare un equilibrio tra antropologia e tecnologia, evitando che la democrazia venga ad estenuarsi in una governance del numero e delle oligarchie tecnocratiche.
(1) Cfr. L. D’Auria (2024, March), «Knowledge Accumulation and Artificial Intelligence: A Marxian Perspective», in Philosophy World Democracy. L. D’Auria (1998), «Valorizzazione capitalistica e crescita della conoscenza», in L. Cillario, R. Finelli (a cura di), Capitalismo e conoscenza. L’astrazione del lavoro nell’era telematica, Manifestolibri, Roma, pp. 87-120.
(2) Su ciò mi permetto di rinviare al mio testo «La dottrina della verità senza la dottrina della città. Per una critica della teoria heideggeriana della tecnica», in R. Finelli (1922), Filosofia e tecnologia. Una via di uscita dalla mente digitale, Rosenberg & Sellier, Torino, pp. 121-167.
(3) Platone, «Protagora», in Dialoghi filosofici, (a cura di G. Cambiano),vol. I, UTET, Torino, 1987, pp. 303- 366.
(4) Su tale tematica Cfr. il fondamentale testo di G. Cambiano (1991), Platone e le tecniche, Laterza, Roma-Bari e Cfr. anche il prezioso lavoro di M. Isnardi Parente (1996), Techne. Momenti del pensiero greco da Platone ad Epicuro, La Nuova Italia, Firenze.
(5) A. Koyrè, Dal mondo del pressappoco all’universo della precisione, Einaudi, Torino 2014.
(6) E. Husserl, L’origine della geometria, Castelvecchi, Roma 2023.
(7) Cfr. a riguardo gli importanti lavori: G. Longo (2019), «Information at the Threshold of Interpretation: Science as Human Constructionof Sense», in M. Bertolaso, F. Sterpetti (a cura di), A Critical Reflection on Automated Science: Will Science Remain Human?, Springer, New York, p. 67-100 e G. Longo (2021), Matematica e senso. Per non divenire macchine, in dialogo con A. Colombo, Mimesis, Milano-Udine.
(8) Su una concezione ritmica, musicale, della corporeità cfr. A.M. Sassone 2011, «E si trasformò in un orecchio», in Consecutio temporum, 1, (www.consecutio.org). In tale prospettiva cfr. anche M. Benasayag (2021), La singolarità del vivente, Jaca Book, Milano.
(9) Anche sul nesso Heidegger-Lacan mi permetto di rinviare ai miei saggi, «Dio ci guarda (i) dall’Uno. Note per una critica affrettata del lacanismo», in In circolo. Rivista di filosofia e cultura, 2019, 7 (www.incircolorivistafilosofica.it) e «Una metafisica troppo nobile del desiderio», in Consecutio rerum, 2019, 4 (www.consecutio.org).
(10) Sulla critica della categoria di “Essere”, come esito di una ipostatizzazione arcaica del linguaggio e di una tradizione indebita di una “parola” in una “cosa”, si vedano gli studi, a mio avviso imprescindibili, sull’origine della filosofia antica di G. Calogero (1967), Storia della logica antica. L’età arcaica, vol. 1, Laterza, Bari, e G. Calogero (1977) Studi sull’eleatismo, La Nuova Italia, Firenze.
(11) J. A. Wheeler (1990), «Information, Physics, Quantum: The Search for Links», in W.H. Zurek (a cura di), Complexity, Entropy, and the Physics of Information, Addison-Wesley Publishing Company, Redwood.
(12) K. Marx (1845), «Tesi su Feuerbach», in Marx-Engels, Opere, vol. V, Editori Riuniti, Roma, 1972, p. 4.
(13) Cfr. A.B. Ferrari (1992), L’eclissi del corpo. Una ipotesi psicoanalitica, Borla, Roma.
(14) Cfr. R. Lombardi (2016), Metà prigioniero, metà alato. La dissociazione corpo-mente in psicoanalisi, Bollati Boringhieri, Torino.
(15) Cfr. su ciò l’ampia produzione di B. Stiegler, in particolare La società automatica. Vol.1. L’avvenire del lavoro, Meltemi, Milano, 2019 e M. Benasayag (in dialogo con A. Pennisi) 2024, ChatGPT non pensa (e il cervello neppure) , Jaca Book, Milano.
(16) I. Kant (1787 seconda edizione), Critica della ragion pura, Einaudi, Torino 1957.
(17) Sulla teoria della genesi e della formazione del pensiero in Bion cfr. W.R. Bion, Apprendere dall’esperienza, Armando, Roma 2009 e Gli elementi della psicoanalisi, Borla, Roma 1995. Cfr. anche C. Neri, A. Correale, P. Fadda, Letture bioniane, Borla, Roma 1994.
(18) Sulla trasformazione e la decadenza culturale della scuola pubblica cfr. AA.VV (a cura di S.Colella, D.Generali, F.Minazzi) 2018, La Scuola dell’ignoranza, Mimesis, Milano, in particolare: D.Generali, «Dal “Progetto 92” alla “Buona Scuola”. Un percorso trentennale di destrutturazione del sistema scolastico nazionale», pp.11-68 e G.Carosotti, «L’ignoranza, obiettivo formativo della nuova scuola», pp.145-192.